Nella serata di venerdì al Lucca Comics & Games 2016, presso il cinema Astra di fronte ad una folta platea di appassionati, è stato proiettato uno dei lungometraggi più attesi di questa stagione cinematografica, targato Studio Ghibli e annunciato da un lungo tam tam sul web: La tartaruga rossa.
Ma facciamo un piccolo passo indietro, era il 2014 quando i fan dello Studio Ghibli di tutto il mondo rimasero scossi da vari rumors secondo i quali la loro amata casa di produzione avrebbe chiuso i battenti per sempre. La vicenda in realtà era il frutto dell’equivoco di un blogger e probabilmente il prodotto di una traduzione troppo zelante delle osservazioni fatte dal produttore Toshio Suzuki, che aveva parlato di una "pausa" nella produzione di anime dopo l'uscita di Quando c'era Marnie (2014) di Hiromasa Yonebayashi. Con quest’ultimo film in pareggio al box office, un Hayao Miyazaki ufficialmente in pensione e uno staff di animatori a piede libero, i fan disorientati si erano chiesti che futuro avrebbe potuto avere lo Studio Ghibli. La Tartaruga Rossa risponde ad alcuni di questi dubbi, anche se è una risposta parziale e potenzialmente fuorviante. Il film rappresenta infatti una sorta di anomalia nel catalogo Ghibli, ai più apparirà familiare ma diverso, anche perché si tratta del primo lungometraggio dello studio prodotto all’estero e frutto di una cooperazione internazionale: diretto da un regista olandese, Michael Dudok de Wit, co-sceneggiato dal regista francese Pascale Ferran, animato in Francia dalla Wild Bunch, e fruibile a tutte le latitudini per via della totale assenza di dialoghi.

Tutto nasce quando Toshio Suzuki, dopo la visione del cortometraggio Father and Daughter, già premio Oscar nel 2000, decide di avvicinare il regista Michael Dudok de Wit con la proposta di realizzare un lungometraggio insieme. Il risultato è uno dei film meno commerciali della Ghibli, ma è anche uno dei più universali, un racconto semplice ed elegante con la purezza di un breve poema.
Un giovane uomo, sopravvissuto a un naufragio e sperduto su uno scoglio desolato in mezzo all'oceano, tenta ostinatamente di fuggire costruendosi delle zattere improvvisate, ma ogni volta che comincia ad allontanarsi dall’isola una tartaruga rossa lo prende di mira colpendo la barca come un ariete e mandandola in frantumi. Quando gli si pone la possibilità di vendicarsi sulla misteriosa creatura, questa si trasforma in una bellissima donna che si unisce a lui come compagna sull'isola deserta.
La sottile metafora non è evidente, ma si svela solo dietro un appassionato e sincero sguardo sull’intimo rapporto uomo/natura, in un mix di avventura e isolamento, e da questo punto di vista La tartaruga rossa è piuttosto convincente, descrivendo un mondo selvaggio che riserva al contempo bellezza e crudeltà. Nessun prologo o titoli di sorta, non sappiamo in che epoca è ambientata la storia: nella scena di apertura il nostro anonimo eroe è scaraventato in mezzo a onde mostruose durante una tempesta che infuria con vera e propria violenza, eppure altre insidie di gran lunga maggiori attendono il novello Robinson Crusoe. Dietro la sua rappresentazione a prima vista idilliaca e generosa, l'isola dispensa doni ma anche pericoli mortali.
Alcune sequenze hanno un gusto particolarmente realistico, quasi documentaristico. Emblematica la sequenza in cui una tartarughina non riesce a raggiungere il mare e viene trascinata via dai granchi: una morte tragica diventa così una cena abbondante. Presto però la storia evolve in qualcosa di più misterioso e meditativo, vira sul piano del surreale e si impregna di una sostanza mitica e fantastica. La narrazione non tradisce nessuna specifica estrazione, piuttosto attinge a un complesso e ricercato coacervo di letteratura e folklore, fra cui si potrebbe tentare di riconoscere la seminale raccolta di storie di fantasmi giapponesi a cura di Lafcadio Hearn (Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things), quest’ultimo aspetto dovuto probabilmente all’influenza di Isao Takahata in qualità di produttore artistico del progetto. Anche se non c'è una sola parola di dialogo nell’arco degli 80 minuti di pellicola, il racconto pone grandi domande (circa l'ambizione e l'accettazione) e la bellezza primordiale emerge da ogni fotogramma.

L’ambientazione si svincola da qualsiasi epoca o contesto storico, lasciando galleggiare l’azione nell’eterno regno della leggenda pura. Gli scenari sono in parte modellati sull’isola di La Digue alle Seychelles, ma al contempo sfoggia lussureggianti di foreste di bambù, come se una parte di Giappone fosse stata trasportata nel bel mezzo dell’Oceano Indiano in un misto di fascinazioni esotiche. Dudok de Wit narra la sua avventura attraverso abili ed essenziali tagli di montaggio, senza l'aggiunta di particolari superflui o ridondanti, in una sorta di minimalismo registico che punta al cuore del racconto. Il film diventa più episodico nella seconda parte, non senza colpi di scena, ma nei minuti finali la trama principale torna prepotentemente in primo piano con una scena conclusiva di dolorosa e struggente malinconia.
Da un punto di vista artistico il film unisce l’artigianalità del disegno manuale con l’animazione al computer, mescolando tecniche e stili artistici orientali e occidentali, per esempio l’intricato ricamo del fogliame sugli alberi è il frutto di un minuzioso lavoro di calligrafia, ma il fruscio del vento che lo fa stormire, così come la pioggia ed altri effetti atmosferici è frutto della CGI. Si combinano vaporosi sfondi a carboncino e ad acquerello con uno spartano character design nel cui tratto si individua una evidente discendenza europea, uno stile di disegno alla Hergé (il creatore di Tintin), più evidente nei dettagli anatomici degli occhi e del naso, mentre la rigorosa composizione delle inquadrature rimanda al mondo fluttuante delle stampe giapponesi Ukiyo-e. Ogni fotogramma ha una sua valenza estetica a sé stante e potrebbe essere stampato e appeso a una parete per la raffinatezza esecutiva e l’estrema cura del dettaglio. Il risultato complessivo è una sequenza di immagini al contempo viscerali ed eteree, che riescono a far immedesimare lo spettatore nei panni di un protagonista in fase di stallo, mai del tutto sicuro di ciò che è reale e di ciò che è immaginato.

A incorniciare il tutto un’intensa colonna sonora, firmata da Laurent Perez Del Mar, che non fa certo rimpiangere le altissime vette emotive già raggiunte da Joe Hisaishi. Merita una menzione, nelle prime fasi di esplorazione dell'isola, la scena in cui l’uomo scivola e cade in una insenatura rocciosa apparentemente senza via d'uscita, la sua unica salvezza è immergersi in profondità e sgusciare attraverso una stretta apertura sottomarina. In questo frangente l’incalzare sinistro della musica per violino da parte del compositore ha un effetto particolarmente drammatico, aggiungendo una tensione claustrofobica e asfissiante che mozza il fiato allo spettatore in sintonia con il protagonista che soffoca lentamente.
Probabilmente gli appassionati che si aspettano un altro Ponyo sulla scogliera rimarranno un po’ delusi, eppure La tartaruga rossa si intona al canone Ghibli molto più di alcuni film offerti negli ultimi anni da alcuni pallidi aspiranti eredi di Miyazaki. Dudok de Wit si muove con disinvoltura negli stessi territori emotivi di Miyazaki e Takahata, riuscendo a creare lo stesso mix irresistibile di meraviglia e desiderio, senza scimmiottarli ma usando un linguaggio del tutto singolare. Dopo il premio Oscar per il corto Father and Daughter, l’olandese si conferma un regista di animazione di primissimo piano. In uno scenario dell’intrattenimento cinematografico dominato da invincibili supereroi, mirabolanti esplosioni e grandinate di proiettili, La tartaruga rossa getta una ventata di aria fresca, una scossa di vita, e offre una delle più gratificanti visioni dell'anno.

Ma facciamo un piccolo passo indietro, era il 2014 quando i fan dello Studio Ghibli di tutto il mondo rimasero scossi da vari rumors secondo i quali la loro amata casa di produzione avrebbe chiuso i battenti per sempre. La vicenda in realtà era il frutto dell’equivoco di un blogger e probabilmente il prodotto di una traduzione troppo zelante delle osservazioni fatte dal produttore Toshio Suzuki, che aveva parlato di una "pausa" nella produzione di anime dopo l'uscita di Quando c'era Marnie (2014) di Hiromasa Yonebayashi. Con quest’ultimo film in pareggio al box office, un Hayao Miyazaki ufficialmente in pensione e uno staff di animatori a piede libero, i fan disorientati si erano chiesti che futuro avrebbe potuto avere lo Studio Ghibli. La Tartaruga Rossa risponde ad alcuni di questi dubbi, anche se è una risposta parziale e potenzialmente fuorviante. Il film rappresenta infatti una sorta di anomalia nel catalogo Ghibli, ai più apparirà familiare ma diverso, anche perché si tratta del primo lungometraggio dello studio prodotto all’estero e frutto di una cooperazione internazionale: diretto da un regista olandese, Michael Dudok de Wit, co-sceneggiato dal regista francese Pascale Ferran, animato in Francia dalla Wild Bunch, e fruibile a tutte le latitudini per via della totale assenza di dialoghi.

Tutto nasce quando Toshio Suzuki, dopo la visione del cortometraggio Father and Daughter, già premio Oscar nel 2000, decide di avvicinare il regista Michael Dudok de Wit con la proposta di realizzare un lungometraggio insieme. Il risultato è uno dei film meno commerciali della Ghibli, ma è anche uno dei più universali, un racconto semplice ed elegante con la purezza di un breve poema.
Un giovane uomo, sopravvissuto a un naufragio e sperduto su uno scoglio desolato in mezzo all'oceano, tenta ostinatamente di fuggire costruendosi delle zattere improvvisate, ma ogni volta che comincia ad allontanarsi dall’isola una tartaruga rossa lo prende di mira colpendo la barca come un ariete e mandandola in frantumi. Quando gli si pone la possibilità di vendicarsi sulla misteriosa creatura, questa si trasforma in una bellissima donna che si unisce a lui come compagna sull'isola deserta.
La sottile metafora non è evidente, ma si svela solo dietro un appassionato e sincero sguardo sull’intimo rapporto uomo/natura, in un mix di avventura e isolamento, e da questo punto di vista La tartaruga rossa è piuttosto convincente, descrivendo un mondo selvaggio che riserva al contempo bellezza e crudeltà. Nessun prologo o titoli di sorta, non sappiamo in che epoca è ambientata la storia: nella scena di apertura il nostro anonimo eroe è scaraventato in mezzo a onde mostruose durante una tempesta che infuria con vera e propria violenza, eppure altre insidie di gran lunga maggiori attendono il novello Robinson Crusoe. Dietro la sua rappresentazione a prima vista idilliaca e generosa, l'isola dispensa doni ma anche pericoli mortali.
Alcune sequenze hanno un gusto particolarmente realistico, quasi documentaristico. Emblematica la sequenza in cui una tartarughina non riesce a raggiungere il mare e viene trascinata via dai granchi: una morte tragica diventa così una cena abbondante. Presto però la storia evolve in qualcosa di più misterioso e meditativo, vira sul piano del surreale e si impregna di una sostanza mitica e fantastica. La narrazione non tradisce nessuna specifica estrazione, piuttosto attinge a un complesso e ricercato coacervo di letteratura e folklore, fra cui si potrebbe tentare di riconoscere la seminale raccolta di storie di fantasmi giapponesi a cura di Lafcadio Hearn (Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things), quest’ultimo aspetto dovuto probabilmente all’influenza di Isao Takahata in qualità di produttore artistico del progetto. Anche se non c'è una sola parola di dialogo nell’arco degli 80 minuti di pellicola, il racconto pone grandi domande (circa l'ambizione e l'accettazione) e la bellezza primordiale emerge da ogni fotogramma.

L’ambientazione si svincola da qualsiasi epoca o contesto storico, lasciando galleggiare l’azione nell’eterno regno della leggenda pura. Gli scenari sono in parte modellati sull’isola di La Digue alle Seychelles, ma al contempo sfoggia lussureggianti di foreste di bambù, come se una parte di Giappone fosse stata trasportata nel bel mezzo dell’Oceano Indiano in un misto di fascinazioni esotiche. Dudok de Wit narra la sua avventura attraverso abili ed essenziali tagli di montaggio, senza l'aggiunta di particolari superflui o ridondanti, in una sorta di minimalismo registico che punta al cuore del racconto. Il film diventa più episodico nella seconda parte, non senza colpi di scena, ma nei minuti finali la trama principale torna prepotentemente in primo piano con una scena conclusiva di dolorosa e struggente malinconia.
Da un punto di vista artistico il film unisce l’artigianalità del disegno manuale con l’animazione al computer, mescolando tecniche e stili artistici orientali e occidentali, per esempio l’intricato ricamo del fogliame sugli alberi è il frutto di un minuzioso lavoro di calligrafia, ma il fruscio del vento che lo fa stormire, così come la pioggia ed altri effetti atmosferici è frutto della CGI. Si combinano vaporosi sfondi a carboncino e ad acquerello con uno spartano character design nel cui tratto si individua una evidente discendenza europea, uno stile di disegno alla Hergé (il creatore di Tintin), più evidente nei dettagli anatomici degli occhi e del naso, mentre la rigorosa composizione delle inquadrature rimanda al mondo fluttuante delle stampe giapponesi Ukiyo-e. Ogni fotogramma ha una sua valenza estetica a sé stante e potrebbe essere stampato e appeso a una parete per la raffinatezza esecutiva e l’estrema cura del dettaglio. Il risultato complessivo è una sequenza di immagini al contempo viscerali ed eteree, che riescono a far immedesimare lo spettatore nei panni di un protagonista in fase di stallo, mai del tutto sicuro di ciò che è reale e di ciò che è immaginato.

A incorniciare il tutto un’intensa colonna sonora, firmata da Laurent Perez Del Mar, che non fa certo rimpiangere le altissime vette emotive già raggiunte da Joe Hisaishi. Merita una menzione, nelle prime fasi di esplorazione dell'isola, la scena in cui l’uomo scivola e cade in una insenatura rocciosa apparentemente senza via d'uscita, la sua unica salvezza è immergersi in profondità e sgusciare attraverso una stretta apertura sottomarina. In questo frangente l’incalzare sinistro della musica per violino da parte del compositore ha un effetto particolarmente drammatico, aggiungendo una tensione claustrofobica e asfissiante che mozza il fiato allo spettatore in sintonia con il protagonista che soffoca lentamente.
Probabilmente gli appassionati che si aspettano un altro Ponyo sulla scogliera rimarranno un po’ delusi, eppure La tartaruga rossa si intona al canone Ghibli molto più di alcuni film offerti negli ultimi anni da alcuni pallidi aspiranti eredi di Miyazaki. Dudok de Wit si muove con disinvoltura negli stessi territori emotivi di Miyazaki e Takahata, riuscendo a creare lo stesso mix irresistibile di meraviglia e desiderio, senza scimmiottarli ma usando un linguaggio del tutto singolare. Dopo il premio Oscar per il corto Father and Daughter, l’olandese si conferma un regista di animazione di primissimo piano. In uno scenario dell’intrattenimento cinematografico dominato da invincibili supereroi, mirabolanti esplosioni e grandinate di proiettili, La tartaruga rossa getta una ventata di aria fresca, una scossa di vita, e offre una delle più gratificanti visioni dell'anno.

La tartaruga rossa affascina e conquista come una favola immortale, celebra la natura primordiale e abbacinante e, allo stesso tempo, narra una storia di sopravvivenza compassionevole e dolorosamente bella, e infine ci ricorda che lo scopo ultimo della grande macchina della natura è sempre la vita.
Pro
- Una visione consigliata a tutti i fan dello Studio Ghibli e non solo.
- Disegni e animazioni allo stato dell’arte.
- Storia avvincente nel segno dell’avventura.
- Eccellente colonna sonora
Contro
- Ritmo dell'azione altalenante










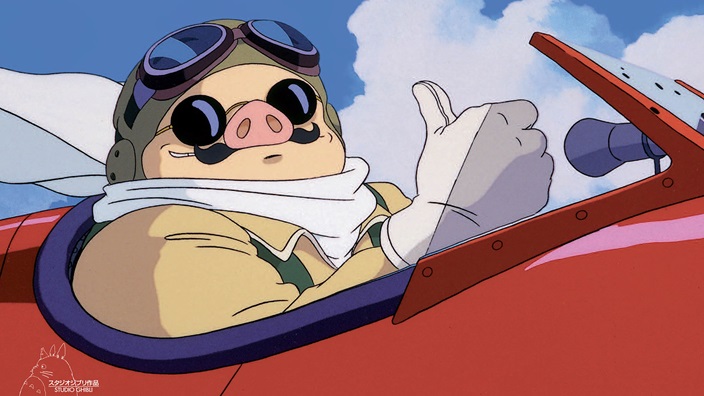




Ultimi 20 anni? No. Impossibile. Non esiste proprio. Se dici ultimi 10 anni ancora ancora, ma 20 anni no.
Cerchiamo di rendergli un minimo di onore in quei 3 giorni che sarà al cinema.
Per quanto mi riguarda è da Totoro che non fanno un film "bellissimo", quindi sarebbero anche più di 20 anni...
Il livello artistico è molto elevato, intendiamoci, ed alcune delle scene raffigurate risultano davvero toccanti e poetiche... ma l'aspetto narrativo non riesce a convincere completamente, forse a causa della difficoltà aggiuntiva derivante dalla mancanza di dialoghi, che obbliga a lasciare alcuni vuoti.. forse per la grande semplificazione nel tratto dei volti, lontanissima dall'espressività delle altre produzioni dello Studio...
Ho cercato di farmi prendere dalla magia degli splendidi fondali, dalla "favola" del racconto.. ma
E va bene l'amore senza frontiere.. ben vengano gli eventi interpretabili da opposti punti di vista... ma dopo gli hentai con i polipi, manco le testuggini sono più al sicuro? >_<
L'impressione si è manifestata proprio palesemente alla fine della proiezione: metà della sala ha applaudito, l'altra metà è rimasta a braccia conserte.
Non arrivo certo a sconsigliarne la visione, è un opera animata peculiare, ma suggerirei anche di non caricarlo di aspettative eccessive.
Mi attirerò una marea di pollici versi, ma sinceramente stavolta passo, e non solo perché si capisce fin troppo chiaramente che non è un Ghibli puro!
Da come lo descrivi pare proprio un film
Veramente in Giappone è stato già distribuito un mese fa dalla Toho... Poi hai visto i titoli di coda in modo da essere sicuro di ciò che dici?
Ho visto i credits sulla scheda del sito ufficiale di Primalinea:
http://www.primalinea.com/latortuerouge/descriptions/index.fr.html
Eh, appunto da quello nascono le sensazioni di perplessità:
Sto portando acqua al mulino della produzione anche con le critiche XD
Precisiamo
Di sicuro non sono completi, è improbabile che all'animazione abbia lavorato il solo Jean-Christophe Lie... Io fin dall'annuncio del progetto ho pensato che lo Studio Ghibli abbia collaborato solo all'animazione, un po' come quando la Disney e la Warner appaltavano l'animazione di alcune serie TV alla TMS.
Subappalto di alcune parti? Potrebbe essere, ma mi sembra un po' poco per definirlo "Il nuovo film targato Ghibli".
Infatti non lo è, su questo siamo d'accordo. Potere del marketing...
Sono curiosa di vederlo! Spero presto!
salve Ren, anche io sono riuscita a vederlo al lucca comics però non ho avuto così tanta fortuna, da un lato mi hanno fatta entrare ma mi sono dovuta sedere sulla mia piccola montagnetta di fumetti acquistati come fosse una piccola sedia, ma il film mi ha preso così tanto che non mi accorgevo quasi di essere seduta su dei fumetti. il film mi è piaciuto tantissimo, ed io non sono una dai gusti facili ed era la prima volta che vedevo un film animato senza dialoghi, dico solo che ad oggi sopo più di 2 settimane me lo ricordo tutto, le immagini, la storia e tutta la trama e le emozioni. una bellissima nuova esperienza di visione di film d'animazione
Allora è vero, ci hanno messo solo i soldi. Ma poi allo Studio Ghibli cosa stanno facendo ora? Magari non hanno neanche più animatori 2D come alla Disney...
Praticamente nulla, penso a cassa integrazione o cose simili; non so come funzionano in Giappone queste cose (non troppo belle).
Beh, io l'ho visto e a parte l'ultimo di Takahata vale lo stesso per me; anzi, di sempre. Ma il punto è: questo film non è giapponese (la co-produzione non c'entra), nè tanto meno ghibliano, ma europeo nella realizzazione e di scuola franco-belga.
C'è l'intervista al regista nell'articolo precedente sul film:
È una collaborazione nei termini che ghibli (Takahata in pratica) ha proposto la collaborazione e cofinanziato il progetto lasciando però produzione e diritti al gruppo franco-belga secondo la legislatura francese su queste cose.
Sul lato produttivo ghibli dovrebbe avere fatto checking e qualche correzione, per quello è accreditato solo lo studio come coproduttore.
E quindi? Dovrebbe voler dire che non è bello quanto un film Ghibli? Si vede che di film d'animazione franco-belgi ne hai visti pochi ultimamente.
Alcuni aspetti sono meravigliosi, qualche punto ti lascia perplesso...
Un film forse non per tutti, ma che a tutti coloro che lo vorranno vedere saprà regalare grandi emozioni, al di là di tutto.
Ultima considerazione su qualche critica letta: il fatto che sia franco-belga nella realizzazione non significa che non sia degno della produzione dello Studio Ghibli.
Trovo invece una grande scelta dello Studio (in particolare di Isaho Takahata) quella di sponsorizzare e produrre un lungometraggio come questo, non commerciale ma sicuramente di qualità e che sa essere emozionante.
Spero che lo stile esagerato del commento nascosto in spoiler sia un tentativo di fare umorismo (nel qual caso mi scuso in anticipo), perché se è un commento serio non riesco dal trattenermi dal dire che sia una grossa stupidaggine... un discorso è il ragionevole dubbio che
La mia personale opinione è che il film non sia adatto ai gusti di tutti ma comunque piacevole. L'ho visto stasera e a fine proiezione ero immobile sprofondata nella poltrona per camuffare la maschera di lacrime. La sala era pietrificata come me, nessuno si è alzato o ha commentato o ha mosso un sopracciglio fino a quando non è scomparso anche l'ultimo titolo di coda e non si è accesa l'ultima luce in sala. A me piace pensare che tutti si stessero come me prendendo il tempo di gestire emotivamente il finale.
(O magari erano appisolati di noia e sono fessa io ?)
E' piaciuto sia a me che ad i miei amici - che in genere non guardano cartoni animati - e siamo stati tutti concordi nell'osservare che malgrado sia un film lento, senza dialoghi e con una trama semplice e lineare non ci sia mai stato un attimo di noia: ha catturato la nostra attenzione dall'inizio alla fine.
Come ha commentato la mia amica, "Si vede proprio che è una coproduzione: è giapponese al 50% e francese al 50%, proprio metà e metà".
Alcune scene sono estremamente poetiche, altre commoventi, altre emotivamente molto forti, ed i disegni e le animazioni sono sempre di altissimo livello, eleganti e con una grande cura dei dettagli.
Consigliatissimo, per quel che mi riguarda.
Anche io mi sono ritrovata più volte a domandarmi sulla realtà di quanto mostrato sullo schermo, soprattutto sul finale, ma non ho mai provato disagio in quanto ho visto, anzi. Questo film è riuscito a emozionarmi dall'inizio alla fine come pochi (insieme al già citato La Storia della Principessa Splendente) e l'assenza di dialoghi, unita a una colonna sonora rilevante, me l'hanno fatto apprezzare ulteriormente.
Quindi, consiglio vivamente la visione di questo film, soprattutto a chi finora ha deciso di tenersene alla larga perché non è propriamente Ghibli (sinceramente, è una questione così importante?).
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.