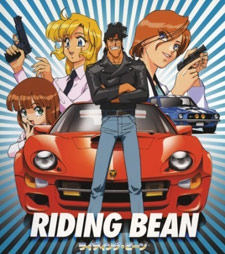Fourth Place
A sedici anni di distanza dal suo sogno olimpico Gwang-soo, ex-promessa del nuoto coreano ormai ritiratosi e dimenticato da tutti, viene contattato da una donna che vuole assumerlo come allenatore per il figlioletto undicenne Joon-ho, nonostante la sua fama di essere un preparatore eccessivamente severo. Il ragazzino dimostra un discreto talento nel nuoto, ma – privo di stimoli competitivi e praticante solo per passione – in gara finora si è sempre piazzato solo al quarto posto. L'uomo inizia così un programma d'allenamento estremamente duro e serrato, non esitando a usare la violenza pur di motivare il bambino.
Con occhio estremamente critico ma mai provocatorio, Jung Ji-woo mette a fuoco un aspetto profondamente radicato quanto atrocemente ordinario della società coreana, nel documentare in modo quasi iperrealistico lo smontaggio fisico e psicologico cui i giovani coreani sono soggetti fin dalla più tenera età. Agli occhi di un occidentale Fourth Place potrebbe forse risultare un tantino esagerato per l'atmosfera soffocante (a tratti quasi annichilente) che si respira, ma come lo stesso regista ha in più occasioni tenuto a specificare la situazione descritta nell'opera si presenta assai più vicina alla realtà di quanto si possa immaginare: le pressioni a cui ogni individuo è sottoposto in una delle società più rigide e competitive al mondo deflagrano dunque in un vortice d'oppressione che sembra non avere fine. Tutti i personaggi sono convinti di essere nel giusto, agiscono spinti da un meccanismo educativo assimilato passivamente, che essi stessi hanno sperimentato sulla propria pelle ormai da anni; Park Hae-jun regala un'interpretazione straordinaria, dando vita alle innumerevoli ombre di un uomo a sua volta tradito e calpestato dalla società, che quasi per ripicca sfoga le proprie delusioni passate in un allenamento cinico e disumanizzante. E sebbene l’intento di far riflettere lo spettatore sia sempre ben definito, il film mantiene volutamente un approccio "esterno", rinunciando coraggiosamente a qualsiasi forma di percorso catartico o redentivo ed evitando in questo modo di (s)cadere in quella che avrebbe potuto essere una furba retorica.
Mentre il piccolo Joon-ho brancola nelle cupe profondità della sua esistenza cercando di seguire una luce sempre più fioca e distante, Gwang-soo non si sforzerà nemmeno di comprendere il punto di vista del bambino, il cui unico desiderio è quello di nuotare privo di vincoli e oppressioni; allo stesso modo la madre (interpretata da una convincente Lee Hang-na) continuerà fino all'ultimo istante a scaricare sugli inermi figli le frustrazioni che a sua volta riceve dal gradino soprastante, in un circolo vizioso destinato a non estinguersi mai. Questa lucida indifferenza, propria di una realtà spietata e selvaggia a livelli disumani, verrà (in parte) sovvertita solo nello straordinaria e metaforica sequenza finale, girata simbolicamente in una lunga soggettiva del protagonista – e di rimando anche dell'autore –, che sarà a sorpresa l'unico segmento in cui Ji-woo abbandona radicalmente il suo approccio documentaristico in favore di una posizione definita all'interno del racconto; regalandoci una toccante sequenza dalle atmosfere oniriche e dilatate, il regista dipinge una rivincita idealistica ma prima di tutto interiore, dove la più pura e genuina soddisfazione personale prende simbolicamente il posto dell'effimero e sofferto appagamento competitivo.
«Come ci si sente ad arrivare primi?»
Con occhio estremamente critico ma mai provocatorio, Jung Ji-woo mette a fuoco un aspetto profondamente radicato quanto atrocemente ordinario della società coreana, nel documentare in modo quasi iperrealistico lo smontaggio fisico e psicologico cui i giovani coreani sono soggetti fin dalla più tenera età. Agli occhi di un occidentale Fourth Place potrebbe forse risultare un tantino esagerato per l'atmosfera soffocante (a tratti quasi annichilente) che si respira, ma come lo stesso regista ha in più occasioni tenuto a specificare la situazione descritta nell'opera si presenta assai più vicina alla realtà di quanto si possa immaginare: le pressioni a cui ogni individuo è sottoposto in una delle società più rigide e competitive al mondo deflagrano dunque in un vortice d'oppressione che sembra non avere fine. Tutti i personaggi sono convinti di essere nel giusto, agiscono spinti da un meccanismo educativo assimilato passivamente, che essi stessi hanno sperimentato sulla propria pelle ormai da anni; Park Hae-jun regala un'interpretazione straordinaria, dando vita alle innumerevoli ombre di un uomo a sua volta tradito e calpestato dalla società, che quasi per ripicca sfoga le proprie delusioni passate in un allenamento cinico e disumanizzante. E sebbene l’intento di far riflettere lo spettatore sia sempre ben definito, il film mantiene volutamente un approccio "esterno", rinunciando coraggiosamente a qualsiasi forma di percorso catartico o redentivo ed evitando in questo modo di (s)cadere in quella che avrebbe potuto essere una furba retorica.
Mentre il piccolo Joon-ho brancola nelle cupe profondità della sua esistenza cercando di seguire una luce sempre più fioca e distante, Gwang-soo non si sforzerà nemmeno di comprendere il punto di vista del bambino, il cui unico desiderio è quello di nuotare privo di vincoli e oppressioni; allo stesso modo la madre (interpretata da una convincente Lee Hang-na) continuerà fino all'ultimo istante a scaricare sugli inermi figli le frustrazioni che a sua volta riceve dal gradino soprastante, in un circolo vizioso destinato a non estinguersi mai. Questa lucida indifferenza, propria di una realtà spietata e selvaggia a livelli disumani, verrà (in parte) sovvertita solo nello straordinaria e metaforica sequenza finale, girata simbolicamente in una lunga soggettiva del protagonista – e di rimando anche dell'autore –, che sarà a sorpresa l'unico segmento in cui Ji-woo abbandona radicalmente il suo approccio documentaristico in favore di una posizione definita all'interno del racconto; regalandoci una toccante sequenza dalle atmosfere oniriche e dilatate, il regista dipinge una rivincita idealistica ma prima di tutto interiore, dove la più pura e genuina soddisfazione personale prende simbolicamente il posto dell'effimero e sofferto appagamento competitivo.
«Come ci si sente ad arrivare primi?»