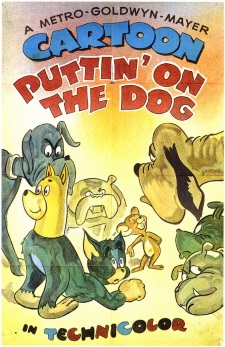Lettere da Iwo Jima
Ispirato al libro "Pictures letters from commander in chief", Letters from Hiwo Jima è il secondo capitolo del progetto di Clint Eastwood dedicato all'epica battaglia combattuta su uno scoglio arido e inospitale del Pacifico da soldati americani e giapponesi: una lotta cruenta che avrebbe segnato le sorti della II Guerra Mondiale.
Il film si contrappone al precedente Flags of our fathers con il quale forma un dittico asimmetrico ma speculare. In entrambe le pellicole i toni sono dominati dalla pietas e dalla compassione per le innumerevoli vittime sacrificate sull'altare della ragion di stato e dell'ottusa logica militare. Del resto le affinità finiscono qui perché siamo di fronte a due opere per altri versi molto differenti. Il regista applica un coraggioso ribaltamento di prospettiva, abbandona la messa in scena spettacolare e un po' eccessiva del primo film, in cui si analizzava criticamente il meccanismo distorto e fagocitante della propaganda (la leggendaria foto scattata ai marines che innalzano lo stars and stripes sul monte Surubachi), per immergersi nell'atmosfera composta, intensa e drammatica del secondo film, che chiude il cerchio e racconta lo stesso episodio storico dal punto di vista nipponico. In Flags il coraggio e l'onore diventano strumento mediatico su scala macroscopica; in Letters, attraverso il filo rosso delle lettere dei soldati imperiali ai loro cari, si osserva il rapporto intimo ed esistenziale con la morte onorevole, in un ottica di rigido patriottismo ed etica kamikaze a sancire il carattere premeditatamente sacrificale di quella battaglia. Inoltre, alle ardite panoramiche di grande respiro di Flags fanno da contraltare gli spazi chiusi e claustrofobici di Letters.
Eastwood delinea le figure del suo teatro bellico con assoluto rigore, sottraendo alla guerra le sue ragioni per lasciar emerger, in contro luce, le ragioni degli uomini, che da ambo le parti finiscono per confondersi risultando molto simili, quando non identiche: le lettere dei nipponici differiscono poco da quelle degli americani, così come non bisogna pensare che il Male sia schierato solo da una delle due parti.
La vicenda ci narra dello scontro impari in cui gli statunitensi (equipaggiati molto meglio) sovrastano in numero gli orientali in proporzione di 5 a 1, e, nonostante l'evidente superiorità, le forze dello zio Sam impiegarono ben più dei cinque giorni stimati per impadronirsi dell'isola: l'irriducibile coraggio e abnegazione dei 20.000 soldati giapponesi (se ne salvarono poco più di mille) contribuì in parte alla decisione definitiva sull'uso dell'atomica.
La follia e l'insensatezza della guerra è tratteggiata in tutte le sue gamme di grigio, grazie ad una fotografia desaturata e monocromatica, salvo sporadici lampi di giallo/arancio (per il fuoco) e squarci di rosso (per il sangue). La toccante sceneggiatura, scritta a quattro mani da Iris Yamashita e dal premio oscar Paul Haggis (Crash), ci restituisce dei ritratti intensissimi e grondanti umanità, che Eastwood dipinge efficacemente ricorrendo a un massiccio uso del flashback. Nel cast spicca l'interpretazione del protagonista Ken Wtanabe nei panni del comandante assegnato alla difesa dell'isola con l'immane compito di resistere il più a lungo possibile. La sua è una figura sfumata nei dettagli e complessa, divisa tra l'appartenenza al credo imperiale e una cultura di più ampio respiro. E' a questo personaggio, con la sua dignità e il suo spessore morale, che il regista affida il compito di lanciare un messaggio che non scade mai in atteggiamenti predicatori.
Senza ipocrisie Eastwood lascia i dialoghi originali in giapponese ma non rinuncia del tutto al suo punto di vista di yankee, non a caso i portatori di vera pietas, e che hanno cognizione di ciò che sta intorno a loro accadendo, sono proprio il comandante e il barone, ovvero gli unici che parlano inglese, essendo stati negli USA, e che conoscono lo stile di vita americano.
A otto anni di distanza dal capolavoro panteistico e metafisico La sottile linea rossa di Terence Malick, Clint Eastwood torna a rivisitare l'inferno delle battaglie nel Pacifico con un film denso e toccante, un poema lucido e dolente che si fa al contempo fiction, documentario storico e profonda coscienza morale, in altre parole Cinema con la "C" maiuscola.
Il film si contrappone al precedente Flags of our fathers con il quale forma un dittico asimmetrico ma speculare. In entrambe le pellicole i toni sono dominati dalla pietas e dalla compassione per le innumerevoli vittime sacrificate sull'altare della ragion di stato e dell'ottusa logica militare. Del resto le affinità finiscono qui perché siamo di fronte a due opere per altri versi molto differenti. Il regista applica un coraggioso ribaltamento di prospettiva, abbandona la messa in scena spettacolare e un po' eccessiva del primo film, in cui si analizzava criticamente il meccanismo distorto e fagocitante della propaganda (la leggendaria foto scattata ai marines che innalzano lo stars and stripes sul monte Surubachi), per immergersi nell'atmosfera composta, intensa e drammatica del secondo film, che chiude il cerchio e racconta lo stesso episodio storico dal punto di vista nipponico. In Flags il coraggio e l'onore diventano strumento mediatico su scala macroscopica; in Letters, attraverso il filo rosso delle lettere dei soldati imperiali ai loro cari, si osserva il rapporto intimo ed esistenziale con la morte onorevole, in un ottica di rigido patriottismo ed etica kamikaze a sancire il carattere premeditatamente sacrificale di quella battaglia. Inoltre, alle ardite panoramiche di grande respiro di Flags fanno da contraltare gli spazi chiusi e claustrofobici di Letters.
Eastwood delinea le figure del suo teatro bellico con assoluto rigore, sottraendo alla guerra le sue ragioni per lasciar emerger, in contro luce, le ragioni degli uomini, che da ambo le parti finiscono per confondersi risultando molto simili, quando non identiche: le lettere dei nipponici differiscono poco da quelle degli americani, così come non bisogna pensare che il Male sia schierato solo da una delle due parti.
La vicenda ci narra dello scontro impari in cui gli statunitensi (equipaggiati molto meglio) sovrastano in numero gli orientali in proporzione di 5 a 1, e, nonostante l'evidente superiorità, le forze dello zio Sam impiegarono ben più dei cinque giorni stimati per impadronirsi dell'isola: l'irriducibile coraggio e abnegazione dei 20.000 soldati giapponesi (se ne salvarono poco più di mille) contribuì in parte alla decisione definitiva sull'uso dell'atomica.
La follia e l'insensatezza della guerra è tratteggiata in tutte le sue gamme di grigio, grazie ad una fotografia desaturata e monocromatica, salvo sporadici lampi di giallo/arancio (per il fuoco) e squarci di rosso (per il sangue). La toccante sceneggiatura, scritta a quattro mani da Iris Yamashita e dal premio oscar Paul Haggis (Crash), ci restituisce dei ritratti intensissimi e grondanti umanità, che Eastwood dipinge efficacemente ricorrendo a un massiccio uso del flashback. Nel cast spicca l'interpretazione del protagonista Ken Wtanabe nei panni del comandante assegnato alla difesa dell'isola con l'immane compito di resistere il più a lungo possibile. La sua è una figura sfumata nei dettagli e complessa, divisa tra l'appartenenza al credo imperiale e una cultura di più ampio respiro. E' a questo personaggio, con la sua dignità e il suo spessore morale, che il regista affida il compito di lanciare un messaggio che non scade mai in atteggiamenti predicatori.
Senza ipocrisie Eastwood lascia i dialoghi originali in giapponese ma non rinuncia del tutto al suo punto di vista di yankee, non a caso i portatori di vera pietas, e che hanno cognizione di ciò che sta intorno a loro accadendo, sono proprio il comandante e il barone, ovvero gli unici che parlano inglese, essendo stati negli USA, e che conoscono lo stile di vita americano.
A otto anni di distanza dal capolavoro panteistico e metafisico La sottile linea rossa di Terence Malick, Clint Eastwood torna a rivisitare l'inferno delle battaglie nel Pacifico con un film denso e toccante, un poema lucido e dolente che si fa al contempo fiction, documentario storico e profonda coscienza morale, in altre parole Cinema con la "C" maiuscola.
Giappone, ultimi mesi del 1944.
Benché l'apparato bellico sia prossimo al collasso, e l'Esercito Imperiale collezioni sconfitte su tutti i fronti, per il Ministero della Guerra la resa è un'ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione: vuoi per un atavico senso dell'onore, esasperato da forti - e folli - correnti nazionaliste, vuoi per l'ottusità tipica di certi ambienti militari, ma il solo parlare di capitolazione è sufficiente per essere etichettato come disfattista.
L'Impero va difeso ad ogni costo, fino all'ultimo uomo.
E non importa che la realtà sui campi di battaglia strida con i proclami dei vertici militari: nel teatro del Pacifico, di fronte alla superiorità americana in termini di mezzi, risorse e tecnologie, i soldati nipponici, a dispetto della propaganda, sono costretti a difendere con le unghie e con i denti le conquiste del primo anno di guerra, inesorabilmente erose dall'efficiente macchina bellica statunitense.
La storia raccontata in "Letters from Iwo Jima" si colloca in questo scenario, nei fatidici mesi in cui l'isolotto dell'Oceano Pacifico, un arido scoglio di roccia vulcanica, diventa improvvisamente per l'America un obiettivo cruciale: una minuscola maglia dell'ultimo anello difensivo giapponese, che ha il pregio di essere una base ideale per accorciare le rotte dei bombardieri diretti sui centri urbani dell'arcipelago, e uno scalo sicuro in caso di emergenza.
Le difese dell'isola vengono affidate al generale Kuribayashi, militare sui generis, di rango aristocratico ma dal carattere schietto ed esuberante - per questo, inviso ai piani alti delle gerarchie di Tokyo: conscio sin dalle prime ispezioni dell'impossibilità di successo dell'operazione affidatagli, lo vedremo dedicarsi anima e corpo all'allestimento della resistenza armata, sfruttando, con l'acume di chi conosce bene l'arte della guerra, le scarse risorse a disposizione.
Nella sua opera di revisione tattica, arriverà perfino a sovvertire, nei mesi precedenti l'attacco, lo stile tradizionale di combattimento dei soldati giapponesi - cosa inconcepibile per gli alti papaveri e per molti dei suoi ufficiali -, ossessionati da sempre dal dover affrontare la morte con 'onore'.
Non più la fine eroica del samurai, la carica suicida sulla battigia sfidando a viso aperto i nemici appena sbarcati, non più urla di guerra o spade sguainate: acquattati nelle trincee, nascosti nei cunicoli sotterranei, i soldati di Kuribayashi dovranno ingaggiare battaglia solo quando i rapporti di forza saranno favorevoli, risparmiando le loro vite per agguati o imboscate.
Vite da non sprecare, da sacrificare a ideali discutibili, con lealtà incondizionata, che faranno emergere con forza la drammaticità del dissidio interiore del generale, tanto premuroso verso le sue truppe al punto da condividerne i disagi, quanto ligio e cinico nell'obbedire agli ordini, benché consapevole dell'ineluttabilità del fato che attende lui e i suoi uomini. Lo stesso fato che incombe minaccioso sul suolo patrio, e che Kuribayashi, con l'olocausto dei suoi soldati, non può far altro che rimandare.
Filtrata attraverso gli occhi sia degli ufficiali di stanza sull'isola, sia, soprattutto, del soldato semplice Saigo, prima impegnato insieme ai suoi commilitoni in estenuanti corvée, poi catapultato nell'inferno di una lotta senza quartiere, Eastwood consegna al suo pubblico una storia dal sapore ecumenico, dipingendo gli orrori della guerra dal punto di vista del 'nemico': calato nell'oscurità dei bunker giapponesi, restituendo dignità all'odiato avversario, il regista americano ci mostra come, in questa tragica epopea, la diversità culturale negli opposti schieramenti sia solo un velo che nasconde sentimenti universali - le lettere inviate dal fronte ai propri cari ne sono la più fulgida testimonianza.
Eroismo e meschinità, codardia e senso dell'onore, crudeltà e magnanimità appartengono a tutti e nessuno: sul palcoscenico della battaglia vengono a galla i chiaroscuri di ogni essere umano, indipendentemente dalla bandiera sotto la quale combatte. Mentre la guerra, proprio per questo, si palesa nella sua grandiosa, spettacolare insensatezza.
Immortalata nella celebre fotografia di Joe Rosenthal - che ritrae i Marines mentre issano la bandiera americana sul monte Suribachi -, la battaglia di Iwo Jima non poteva sperare in un adattamento cinematografico migliore, che rendesse giustizia alle migliaia di caduti tra vincitori e vinti: tanti, troppi, tanto che l'opinione pubblica dell'epoca ne fu scossa profondamente, e la strategia americana ne venne probabilmente influenzata - abbandonati i propositi di invasione del Giappone, essa ripiegò, per risolvere il conflitto, sull'utilizzo degli ordigni atomici.
"Letters from Iwo Jima" è un film d'autore, tecnicamente ineccepibile, con effetti speciali di prim'ordine ma non invasivi, da vedere assolutamente in versione originale con sottotitoli (per chi è abituato ai fansub non è certo un ostacolo!), crudo in certe scene - seppur la regia non si compiaccia nell'ostentarle - e tendente al patetico (forse troppo) in alcune altre, ma che resta un autentico must per gli amanti del cinema di guerra.
Scevra da quella retorica militarista che, sfacciatamente, fa mostra di sé in tanti film bellici, "Letters from Iwo Jima" è una pellicola anomala, focalizzata sugli uomini più che sugli eventi, la cui poetica è da ricercare nel cablogramma d'addio inviato da Kuribayashi al quartier generale, in particolare nelle audaci e commoventi parole della poesia funebre da lui composta in chiusa, mentre a pochi passi infuriano gli ultimi feroci combattimenti:
Impossibilitato ad adempiere a questo duro compito per il nostro Paese,
frecce e pallottole esaurite, tristi siamo caduti.
Benché l'apparato bellico sia prossimo al collasso, e l'Esercito Imperiale collezioni sconfitte su tutti i fronti, per il Ministero della Guerra la resa è un'ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione: vuoi per un atavico senso dell'onore, esasperato da forti - e folli - correnti nazionaliste, vuoi per l'ottusità tipica di certi ambienti militari, ma il solo parlare di capitolazione è sufficiente per essere etichettato come disfattista.
L'Impero va difeso ad ogni costo, fino all'ultimo uomo.
E non importa che la realtà sui campi di battaglia strida con i proclami dei vertici militari: nel teatro del Pacifico, di fronte alla superiorità americana in termini di mezzi, risorse e tecnologie, i soldati nipponici, a dispetto della propaganda, sono costretti a difendere con le unghie e con i denti le conquiste del primo anno di guerra, inesorabilmente erose dall'efficiente macchina bellica statunitense.
La storia raccontata in "Letters from Iwo Jima" si colloca in questo scenario, nei fatidici mesi in cui l'isolotto dell'Oceano Pacifico, un arido scoglio di roccia vulcanica, diventa improvvisamente per l'America un obiettivo cruciale: una minuscola maglia dell'ultimo anello difensivo giapponese, che ha il pregio di essere una base ideale per accorciare le rotte dei bombardieri diretti sui centri urbani dell'arcipelago, e uno scalo sicuro in caso di emergenza.
Le difese dell'isola vengono affidate al generale Kuribayashi, militare sui generis, di rango aristocratico ma dal carattere schietto ed esuberante - per questo, inviso ai piani alti delle gerarchie di Tokyo: conscio sin dalle prime ispezioni dell'impossibilità di successo dell'operazione affidatagli, lo vedremo dedicarsi anima e corpo all'allestimento della resistenza armata, sfruttando, con l'acume di chi conosce bene l'arte della guerra, le scarse risorse a disposizione.
Nella sua opera di revisione tattica, arriverà perfino a sovvertire, nei mesi precedenti l'attacco, lo stile tradizionale di combattimento dei soldati giapponesi - cosa inconcepibile per gli alti papaveri e per molti dei suoi ufficiali -, ossessionati da sempre dal dover affrontare la morte con 'onore'.
Non più la fine eroica del samurai, la carica suicida sulla battigia sfidando a viso aperto i nemici appena sbarcati, non più urla di guerra o spade sguainate: acquattati nelle trincee, nascosti nei cunicoli sotterranei, i soldati di Kuribayashi dovranno ingaggiare battaglia solo quando i rapporti di forza saranno favorevoli, risparmiando le loro vite per agguati o imboscate.
Vite da non sprecare, da sacrificare a ideali discutibili, con lealtà incondizionata, che faranno emergere con forza la drammaticità del dissidio interiore del generale, tanto premuroso verso le sue truppe al punto da condividerne i disagi, quanto ligio e cinico nell'obbedire agli ordini, benché consapevole dell'ineluttabilità del fato che attende lui e i suoi uomini. Lo stesso fato che incombe minaccioso sul suolo patrio, e che Kuribayashi, con l'olocausto dei suoi soldati, non può far altro che rimandare.
Filtrata attraverso gli occhi sia degli ufficiali di stanza sull'isola, sia, soprattutto, del soldato semplice Saigo, prima impegnato insieme ai suoi commilitoni in estenuanti corvée, poi catapultato nell'inferno di una lotta senza quartiere, Eastwood consegna al suo pubblico una storia dal sapore ecumenico, dipingendo gli orrori della guerra dal punto di vista del 'nemico': calato nell'oscurità dei bunker giapponesi, restituendo dignità all'odiato avversario, il regista americano ci mostra come, in questa tragica epopea, la diversità culturale negli opposti schieramenti sia solo un velo che nasconde sentimenti universali - le lettere inviate dal fronte ai propri cari ne sono la più fulgida testimonianza.
Eroismo e meschinità, codardia e senso dell'onore, crudeltà e magnanimità appartengono a tutti e nessuno: sul palcoscenico della battaglia vengono a galla i chiaroscuri di ogni essere umano, indipendentemente dalla bandiera sotto la quale combatte. Mentre la guerra, proprio per questo, si palesa nella sua grandiosa, spettacolare insensatezza.
Immortalata nella celebre fotografia di Joe Rosenthal - che ritrae i Marines mentre issano la bandiera americana sul monte Suribachi -, la battaglia di Iwo Jima non poteva sperare in un adattamento cinematografico migliore, che rendesse giustizia alle migliaia di caduti tra vincitori e vinti: tanti, troppi, tanto che l'opinione pubblica dell'epoca ne fu scossa profondamente, e la strategia americana ne venne probabilmente influenzata - abbandonati i propositi di invasione del Giappone, essa ripiegò, per risolvere il conflitto, sull'utilizzo degli ordigni atomici.
"Letters from Iwo Jima" è un film d'autore, tecnicamente ineccepibile, con effetti speciali di prim'ordine ma non invasivi, da vedere assolutamente in versione originale con sottotitoli (per chi è abituato ai fansub non è certo un ostacolo!), crudo in certe scene - seppur la regia non si compiaccia nell'ostentarle - e tendente al patetico (forse troppo) in alcune altre, ma che resta un autentico must per gli amanti del cinema di guerra.
Scevra da quella retorica militarista che, sfacciatamente, fa mostra di sé in tanti film bellici, "Letters from Iwo Jima" è una pellicola anomala, focalizzata sugli uomini più che sugli eventi, la cui poetica è da ricercare nel cablogramma d'addio inviato da Kuribayashi al quartier generale, in particolare nelle audaci e commoventi parole della poesia funebre da lui composta in chiusa, mentre a pochi passi infuriano gli ultimi feroci combattimenti:
Impossibilitato ad adempiere a questo duro compito per il nostro Paese,
frecce e pallottole esaurite, tristi siamo caduti.